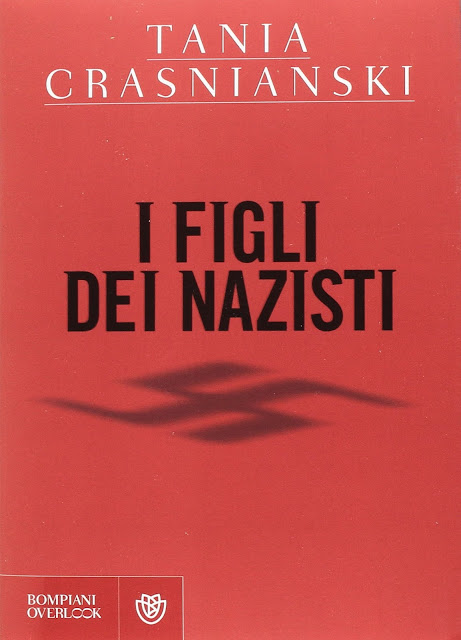C’è stato un tempo in cui Charles Dickens, prima di inaugurare la
sua carriera di romanziere col Circolo Pickwick, scriveva per i
giornali di Londra sotto lo pseudonimo di «Boz». Il risultato di questa
attività di reporter non doveva sembrare del tutto trascurabile, dal
momento che lo stesso Dickens decise di servirsene per consolidare
l’astro nascente della propria fama. Mentre già cominciava a riscuotere i
primi strepitosi successi, non solo con
Pickwick, ma anche grazie a
Oliver Twist e
Nicholas Nickleby,
lo scrittore si impegnò infatti a raccogliere gli svariati «bozzetti»
giornalistici che costituivano i primi «tentativi» della sua
«professione», riproponendoli a più riprese, fra il 1836 e il 1839, nei
due volumi degli
Sketches by Boz.
A richiamare l’attenzione su questa fase di apprendistato, finora
ignorata dall’editoria italiana, interviene oggi Amori londinesi
(Mattioli 1885, pp. 238, euro > 16,90) ultimo volume di una trilogia
che incorpora anche I Londinesi e Il grande romanzo di Londra. Assieme
alla prima traduzione inedita degli Sketches, la trilogia ci propone
subito una piccola sfida: bisogna riconoscere che i materiali finalmente
messi a nostra disposizione si rifiutano di essere trattati come un
repertorio di motivi sviluppati in seguito da Dickens, su più vasta
scala, nei romanzi di nostra conoscenza. Poiché «Boz» ci invita a
prendere in considerazione i restrittivi vincoli di spazio a cui sono
soggetti i suoi «schizzi», incommensurabili al romanzo, dovremo
limitarci a intendere questi testi di varia natura come un atto
inaugurale. I bozzetti ci appariranno, a questi patti, come la prima
occasione in cui Dickens si presenta sulla scena, seppure sotto mentite
spoglie, per reclamare a gran voce i diritti i e poteri di un mago
incantatore determinato a esibire sortilegi di prodigiosa affabulazione.
Non lasciamoci innanzitutto depistare dal travestimento di Boz, che
fin dal Grande romanzo di Londra si presenta nei panni dell’inviato
speciale. Non appena il suo sguardo di «osservatore» girovago si posa su
un anfratto qualsiasi della città, il reporter in perlustrazione cede
il passo allo stregone illusionista, che dopo essersi issato su un
ideale palcoscenico si appresta a evocare l’incantesimo della vita
quotidiana. In questo modo, sull’immaginario telone bianco allestito
alle spalle di Boz, vediamo rinascere sobborghi, piazze e bassifondi,
destinati a poco a poco a popolarsi di «tipi» caratteristici della low e
della middle-class altrimenti banditi dai territori della letteratura
romanzesca.
Sono proprio le epifanie di queste figure «tipiche», ancora
sprovviste di una storia, eppure animate da un frenetico andirivieni di
dialoghi e situazioni, che ci spingono a chiederci come Boz riesca a
generare la magia di una verosimiglianza tanto portentosa.
Essenziale al successo dell’operazione risulta, fin da ora,
l’attitudine teatrale che Dickens riesumerà anche quando negli anni
successivi salirà sul podio in prima persona, durante le pubbliche
letture delle sue opere più amate. È vero però che la teatralità, nel
caso di Boz, rappresenta una risorsa preziosa e al tempo stesso un
infido alleato. La mania di protagonismo, da una parte, consente infatti
al giornalista di balzare agli occhi del pubblico e di manovrarlo come
un regista incontrastato nello spettacolo illusionistico dei bozzetti;
dall’altra, l’incontenibile esuberanza del narratore sulla scena lo
conduce a esporsi troppo agli sguardi, alla stregua di un prestigiatore
che non sa celare fino in fondo i trucchi della propria arte.
Non è difficile accorgersi che per fomentare l’illusione Boz ricorre
di preferenza al «presente storico», uno dei più importanti
«costituenti» – secondo Harald Weinrich – della narrativa «eccitante»,
molto più efficace del passato remoto nella simulazione di scene in
presa diretta. Insistenti risultano poi gli inviti a partecipare ai
sopralluoghi dell’incantatore e a concentrare gli sguardi sui dettagli
da lui stabiliti, per poi «immaginare» il fondale dei suoi scenari. È
come se fossimo istigati, pagina dopo pagina, a seguire le istruzioni di
un ipnotista che ci costringe a cadere nella trance di una finzione
meticolosamente organizzata.
Ossessivo, a questo proposito, diventa il desiderio di suddividere in
categorie precise la popolazione dell’universo immaginato, che finisce
per costituire, come in una lanterna magica, il riflesso ingigantito di
una realtà sociale condivisa e verificabile dagli ascoltatori. La mania
del catalogo si fa talmente invasiva, soprattutto negli Amori londinesi,
da spingerci stavolta a domandare da quali fonti Boz potesse attingere
tanta sapienza e a quale scopo si ingegnasse a riversarla sui suoi primi
lettori.
Sarebbe riduttivo attribuire al bozzettista una vocazione di denuncia
sociologica, così come risulterebbe fuorviante scorgere dietro la sua
maschera la fisionomia del romanziere o dello storico. Perché Boz
comprende e al tempo stesso riesce a superare tutte queste figure. E se
per un verso sembra condividere alcuni dei loro protocolli, per l’altro
si affretta a specificare che i suoi schizzi racchiudono maggior vita
rispetto alle documentazioni degli storici, mentre si divertono a
scimmiottare le convenzionali trovate dei romanzieri. Semmai, Boz può
essere equiparato a uno sciamano dei tempi moderni, a cui basta un
oggetto dimenticato in una vetrina di cianfrusaglie per evocare
l’universo sepolto dietro le loro superfici.
Il suo sapere dipende – come osservava Curtius a proposito di Balzac –
da una «seconda vista» che segue le piste della «intuizione
divinatoria». E non è raro avere l’impressione che nel corso delle sue
performance Boz si ritrovi a contatto coi fantasmi, in procinto di
scatenare forze dell’occulto in una singolare seduta spiritica. Anche
per questo, a detta di Chesterton, tanto i personaggi di Dickens quanto
le figure dei suoi bozzetti sembrano godere di una «divina
pre-esistenza», che li porta ad esistere «prima ancora che lo stesso
Dickens ne abbia sentito parlare». Il risultato, in ogni caso, coincide
con qualcosa di inclassificabile, eccessivo e debordante, che finisce
per travolgere ogni ostacolo sul suo percorso. Lo testimoniano meglio di
tutti i racconti del secondo volume dei Londinesi, dove lo scioglimento
precipita sui lettori all’improvviso e senza preparazione, quasi a
scorciare una narrazione altrimenti pronta a moltiplicarsi fino ad
esplodere.
Non è allora un caso se il soprannome Boz deriva – secondo quanto
Dickens testimonia nella prefazione a Pickwick – dalla storpiatura di
«Moses»: la sua parola e il suo atteggiamento appartengono a qualcuno
che è deciso ad «aprire le acque», a farsi strada a ogni costo, ad
abbattere i confini e le barriere di genere. Anche a prezzo di sarcasmi,
buffonerie clownesche, smargiassate da imbonitore che spesso si
incuneano nelle pagine della «trilogia» conducendole alla farsa, senza
riuscire a nascondere le trame di un progetto utilitaristico.
Esemplare, in questo senso, è l’ultimo volume degli Amori londinesi,
che in aperta ostilità con la «diabolica» misoginia di un libello in
circolazione si impegna a passare in rassegna i tratti fisiognomici, i
tic e le pecche caratteriali di ogni categoria del genere maschile.
Al pubblico delle sue lettrici, Boz offre una galleria di identikit,
assemblati e messi in situazione attraverso una sorta di manuale
assertivo e derisorio, con cui orientarsi nella scelta del perfetto
pretendente. Solo al termine della kermesse il narratore si decide a
proporsi come il «giovane» fidanzato ideale, svelandosi come rivale
diretto di tutti quei partiti che la sua scrittura si è affrettata a
distruggere e mettere in ridicolo. Ma allora, il piano di Boz può essere
considerato altrettanto «diabolico» di quello del suo misogino
predecessore: dietro una nobile vocazione sociologica, gli Amori
londinesi non fanno che nascondere una trappola utilitaristica e
premeditata, allo scopo di puntare i riflettori della narrazione sul
loro artefice.
Allo stesso modo, l’ombra del sospetto finisce per gravitare su tutti
gli altri bozzetti della raccolta. Con questi schizzi, Dickens non ha
voluto soltanto educare i lettori alla dirompente esuberanza dei suoi
futuri romanzi: ha cercato anche di sondare la resistenza dei suoi
ascoltatori, di assicurarseli e di pilotare il loro gusto, dirigendo le
luci della ribalta sulla propria figura. In attesa di varcare la terra
del romanzo, lo scrittore usa Moses – e Boz – per spianarsi il cammino.
[Ivan Tassim 08/02/2017]