Nato nel 1962, coetaneo di David Foster Wallace e di Jennifer
Egan, poeta prestato alla narrativa – cui aveva già regalato tre libri
di notevole livello (uno solo dei quali tradotto in italiano) – Paul
Beatty è andato sempre più consolidandosi, nel corso degli anni e
insieme a Colson Whitehead e John Edgar Wideman, come una delle voci più
originali e convincenti della letteratura afroamericana contemporanea.
Con il suo quarto romanzo, Lo schiavista, proposto –
come già Slumberland – da Fazi (pp. 370, euro 18,50 euro), nella
traduzione davvero eccellente di Silvia Castoldi, ha ottenuto una vera e
propria consacrazione, conseguendo il National Book Critics Circle
Award e entrando con autorevolezza nella rosa dei finalisti del Man
Booker Prize.
Chi aveva ancora dubbi sui meriti dell’autore ha dovuto ricredersi: Beatty rappresenta l’esempio forse più luminoso della strada che la letteratura afroamericana ha saputo percorrere negli ultimi anni, liberandosi dall’obbligo del realismo e della denuncia sociale, che ne aveva fortemente limitato lo spettro d’azione, senza peraltro rinunciare a parlare – in modo forse ancor più forte e convincente, e ricorrendo alle armi della satira, del gioco linguistico, del pastiche, e di un umorismo sfrenato – delle questioni razziali e più in generale delle disuguaglianze che attanagliano un’America sempre più lontana dal suo sogno.
Se in Slumberland buona parte della trama si svolgeva in Europa, per la precisione a Berlino negli anni della caduta del muro, il setting dello schiavista è Dickens: una minuscola cittadina della Los Angeles Area fondata nel secondo ottocento come comunità agricola, per poi trasformarsi in un ghetto per neri e finire cancellata dalla gentrification. Ed è proprio per ribellarsi contro l’obliterazione della città in cui è nato che il protagonista, Bonbon Me – già segnato dall’uccisione del padre sociologo da parte della polizia – comincia la sua personale guerra contro il governo degli Stati Uniti: prima ridisegnando i confini di Dickens con la vernice bianca; poi cercando di reintrodurre la segregazione razziale – in fondo, non c’è niente di meglio dell’apartheid per restaurare un senso di comunità tra gli afroamericani – e ficcandosi così nel gigantesco pasticcio che lo porterà davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti (dove lo troviamo nel lungo, esilarante prologo del romanzo).
BonBon Me è un personaggio sui generis: se tenta di farsi strada nella vita non è nel nome di un desiderio di autoaffermazione razziale, ma tutt’al più assecondando la «frenesia edipica di compiacere il padre». Il suo rapporto con l’identità afroamericana viene formulato con la massima chiarezza in uno dei primi capitoli dello Schiavista: «Ora, se dipendesse solo da me, non potrebbe importarmene di meno di essere nero. A tutt’oggi quando mi arriva per posta il modulo dell’anagrafe, sotto la voce «Razza» barro la casella «Altro» e nello spazio accanto scrivo orgogliosamente «californiano».
Naturalmente due mesi dopo un impiegato dell’anagrafe si presenta a casa mia, mi dà un’occhiata e dice: «Razza di sporco negro. In quanto nero, cos’hai da dire a tua discolpa?». E in quanto nero, non ho mai niente da dire a mia discolpa. Quindi ho bisogno di un motto: se lo avessimo, alzerei il pugno, lo griderei forte e sbatterei la porta in faccia al governo. Ma non ce l’abbiamo. Perciò borbotto: «Mi scusi», e scarabocchio le mie iniziali accanto alla casella con la scritta “Nero, afroamericano, vigliacco”». Questo improbabile antieroe si fa portatore di un progetto paradossale, una sorta di antiutopia che, pure, ha una sua ragione profonda. Nel decimo capitolo dello Schiavista, BonBon mette in scena, sull’autobus guidato dall’ex amore della sua vita, Marpessa, la versione invertita di «quel giorno d’inverno nello Stato segregazionista dell’Alabama», in cui Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un bianco. Incolla sotto i finestrini cartelli a caratteri bianchi e azzurri: «Posti riservati agli anziani, ai disabili e ai bianchi».
Passati in rassegna i mille episodi che, nel corso del Novecento, hanno fatto di Los Angeles l’epitome del razzismo americano (dall’internamento di massa dei nippoamericani, evocato recentemente da James Ellroy in Perfidia, agli urban riots del 1992, seguiti al brutale pestaggio di Rodney King da parte della polizia), BonBon chiarisce la sua visione della storia degli Stati Uniti: l’integrazione etnica – come del resto quella sociale – si è rivelata un autentico fallimento, e agli afroamericani non resta che l’autoghettizzazione come scelta e paradossale diritto.
In un paese sconvolto dalla recrudescenza del conflitto razziale già in corso quando Lo schiavista è stato scritto, e che diventa ogni giorno più evidente, Beatty torna a sfruttare, con maturità ormai piena, le armi e le tecniche di racconto a lui più congeniali: fonde la tradizione umoristica afroamericana e quella satirica che da Twain passa per Vonnegut e approda a Saunders. E costruisce un edificio narrativo denso di riferimenti storici e culturali, a volte quasi sovraccarico, ma che sa illuminare, con le1eggerezza profonda, i contrasti e gli abissi di una società in declino.
[Luca Briasco 23/ 10/2016]
Chi aveva ancora dubbi sui meriti dell’autore ha dovuto ricredersi: Beatty rappresenta l’esempio forse più luminoso della strada che la letteratura afroamericana ha saputo percorrere negli ultimi anni, liberandosi dall’obbligo del realismo e della denuncia sociale, che ne aveva fortemente limitato lo spettro d’azione, senza peraltro rinunciare a parlare – in modo forse ancor più forte e convincente, e ricorrendo alle armi della satira, del gioco linguistico, del pastiche, e di un umorismo sfrenato – delle questioni razziali e più in generale delle disuguaglianze che attanagliano un’America sempre più lontana dal suo sogno.
Se in Slumberland buona parte della trama si svolgeva in Europa, per la precisione a Berlino negli anni della caduta del muro, il setting dello schiavista è Dickens: una minuscola cittadina della Los Angeles Area fondata nel secondo ottocento come comunità agricola, per poi trasformarsi in un ghetto per neri e finire cancellata dalla gentrification. Ed è proprio per ribellarsi contro l’obliterazione della città in cui è nato che il protagonista, Bonbon Me – già segnato dall’uccisione del padre sociologo da parte della polizia – comincia la sua personale guerra contro il governo degli Stati Uniti: prima ridisegnando i confini di Dickens con la vernice bianca; poi cercando di reintrodurre la segregazione razziale – in fondo, non c’è niente di meglio dell’apartheid per restaurare un senso di comunità tra gli afroamericani – e ficcandosi così nel gigantesco pasticcio che lo porterà davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti (dove lo troviamo nel lungo, esilarante prologo del romanzo).
BonBon Me è un personaggio sui generis: se tenta di farsi strada nella vita non è nel nome di un desiderio di autoaffermazione razziale, ma tutt’al più assecondando la «frenesia edipica di compiacere il padre». Il suo rapporto con l’identità afroamericana viene formulato con la massima chiarezza in uno dei primi capitoli dello Schiavista: «Ora, se dipendesse solo da me, non potrebbe importarmene di meno di essere nero. A tutt’oggi quando mi arriva per posta il modulo dell’anagrafe, sotto la voce «Razza» barro la casella «Altro» e nello spazio accanto scrivo orgogliosamente «californiano».
Naturalmente due mesi dopo un impiegato dell’anagrafe si presenta a casa mia, mi dà un’occhiata e dice: «Razza di sporco negro. In quanto nero, cos’hai da dire a tua discolpa?». E in quanto nero, non ho mai niente da dire a mia discolpa. Quindi ho bisogno di un motto: se lo avessimo, alzerei il pugno, lo griderei forte e sbatterei la porta in faccia al governo. Ma non ce l’abbiamo. Perciò borbotto: «Mi scusi», e scarabocchio le mie iniziali accanto alla casella con la scritta “Nero, afroamericano, vigliacco”». Questo improbabile antieroe si fa portatore di un progetto paradossale, una sorta di antiutopia che, pure, ha una sua ragione profonda. Nel decimo capitolo dello Schiavista, BonBon mette in scena, sull’autobus guidato dall’ex amore della sua vita, Marpessa, la versione invertita di «quel giorno d’inverno nello Stato segregazionista dell’Alabama», in cui Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull’autobus a un bianco. Incolla sotto i finestrini cartelli a caratteri bianchi e azzurri: «Posti riservati agli anziani, ai disabili e ai bianchi».
Passati in rassegna i mille episodi che, nel corso del Novecento, hanno fatto di Los Angeles l’epitome del razzismo americano (dall’internamento di massa dei nippoamericani, evocato recentemente da James Ellroy in Perfidia, agli urban riots del 1992, seguiti al brutale pestaggio di Rodney King da parte della polizia), BonBon chiarisce la sua visione della storia degli Stati Uniti: l’integrazione etnica – come del resto quella sociale – si è rivelata un autentico fallimento, e agli afroamericani non resta che l’autoghettizzazione come scelta e paradossale diritto.
In un paese sconvolto dalla recrudescenza del conflitto razziale già in corso quando Lo schiavista è stato scritto, e che diventa ogni giorno più evidente, Beatty torna a sfruttare, con maturità ormai piena, le armi e le tecniche di racconto a lui più congeniali: fonde la tradizione umoristica afroamericana e quella satirica che da Twain passa per Vonnegut e approda a Saunders. E costruisce un edificio narrativo denso di riferimenti storici e culturali, a volte quasi sovraccarico, ma che sa illuminare, con le1eggerezza profonda, i contrasti e gli abissi di una società in declino.
[Luca Briasco 23/ 10/2016]












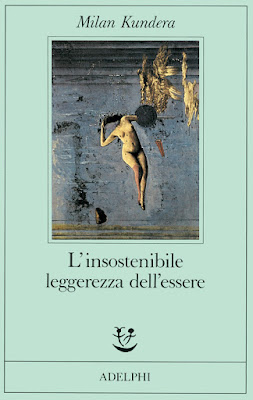

 P
P


